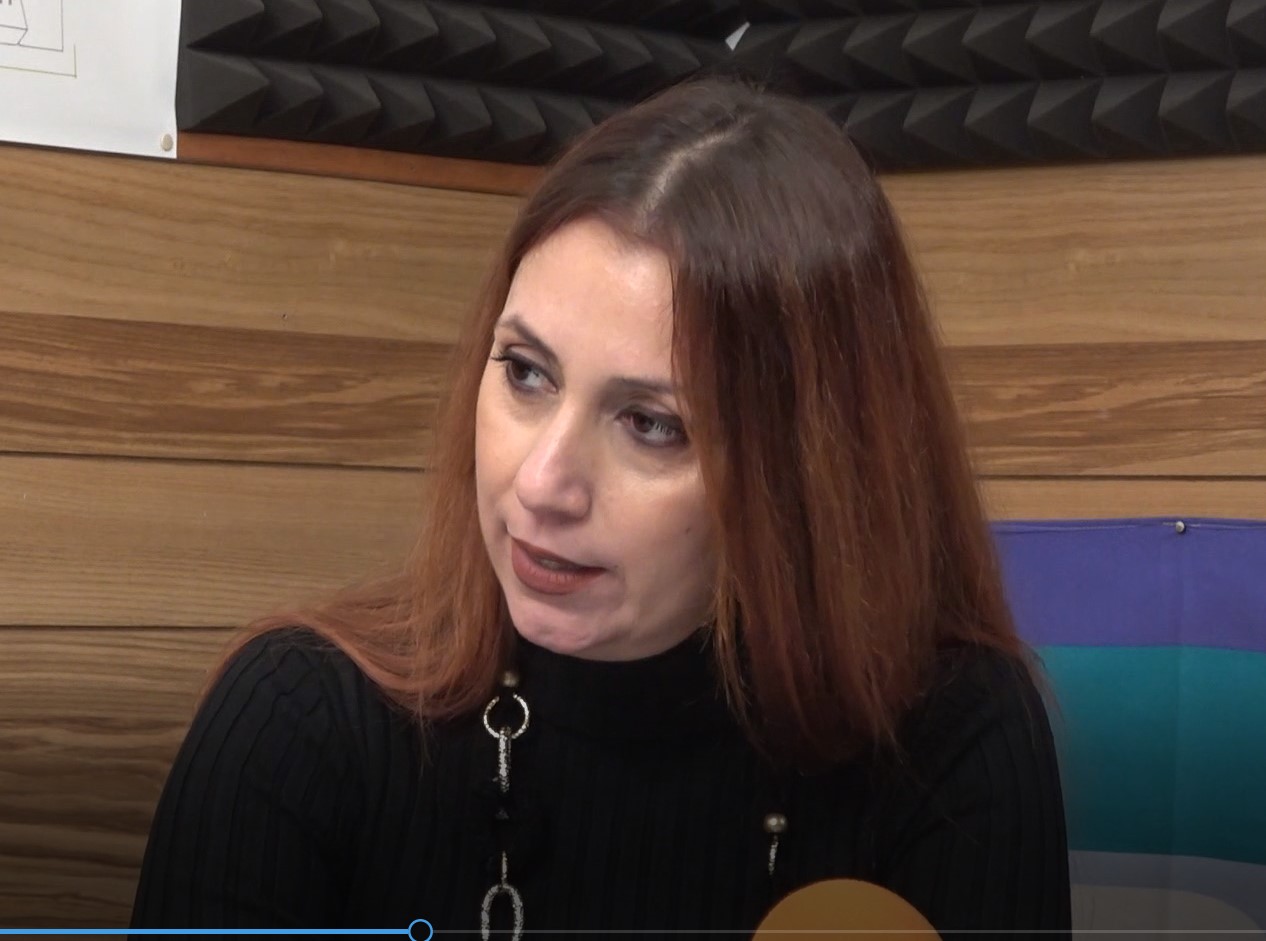La piazza. Polverosa, nel cuore della città: un quadrivio, e macchine che salgono e scendono, persone dal passo affrettato, immerse nei loro pensieri.
Il palazzo. Marrone, imbrattato di fuliggine; le persiane di un verde brillante, restaurate da poco. La merceria, il negozio di fiori.
Il sole. Quel sole che torna a brillare, a lucidare l’asfalto, a infuocare le lamiere delle macchine posteggiate, i sellini dei motori; il marciapiede su cui incede il mio passo, frettoloso, che corre da te.
Quel portone. Accostato, aperto da chi sa già che sto per arrivare, e mi aspetta. Con ansia? Con amore? O fosse anche come si aspetta qualcosa che si è soliti ricevere … Una routine, una pausa-caffè, un passatempo. Un niente che va incontro al nulla. L’effimero, il volatile.
Il momento, che nasce con la consapevolezza che deve morire. E che ha con sé quel puzzo di fiori morti, di bare di noce, di marce funebri.
Oppure è vita che si consacra, la vita che vorremmo, al di là delle maschere, dei doveri, delle ipocrisie. Quello che vorremmo essere e che non siamo, o forse quello che siamo nella nostra faccia nascosta, quella che mostriamo all’altro emisfero del mondo, a quel portone accostato, anch’esso marrone, lucido, lucidissimo, restaurato da poco.
La portineria. Lo specchio, sulla destra. Riflette la mia immagine che passa, mentre corro frettolosa verso l’ascensore. Riflette impietoso, veritiero. Una donna scarmigliata, che si tuffa negli abissi, nella parte oscura di se stessa. Occulta e occultata. Dai doveri, dalla famiglia. Dalla società. Dalla religione. Eppure una donna che vorrebbe ritrovare se stessa. La sua vera identità.
Riflette la mia anima, o solo il mio viso arrossato dalla foga della corsa verso di te?
E chi sei tu?
Un uomo, un demonio, il peccato, il male, l’oscuro. Il mio oscuro, il tuo. Oppure un angelo, l’angelo salvifico, che mi porta in Paradiso, che mi imbratta per redimermi. O solo mi sporca, divertito, sadico, cattivo.
Cosa è bene? Cosa, male? Cos’è la morale? Dio, dove sei?
Le scale. Tre, di marmo bianco.
Portano all’ascensore. Antico, come il palazzo. Avvolto di grate di ferro. Grate, come quelle di una prigione. Grate attraverso cui passa l’immagine dei pianerottoli, squadrati, con le porte ancora una volta marroni, ancora una volta restaurate, lucidate, portate a nuovo. Ma vecchie, stantìe, oltre il lucido, oltre.
Grate. Come quelle di una prigione.
Eppure tu mi dici che in quell’ora in cui noi ci vediamo siamo liberi.
Liberi di essere noi stessi, di vivere il nostro amore, le nostre pulsioni. Di dare sfogo al nostro desiderio, imperioso, esigente, al di là delle famiglie, delle maschere. Dei presepi di Capodimonte, in cui ci esibiamo, quando siamo la faccia illuminata dal sole, quel sole che riscalda i miei passi.
Siamo liberi? O ci imprigioniamo in un’immagine sbagliata di noi stessi? O ci imprigioniamo nel peccato? Nel dolore di non potere essere noi stessi agli occhi del mondo, quel mondo polveroso che cammina, sui marciapiedi rotti, apparentemente indifferente, ma pronto a ucciderci, nel caso in cui volessimo esibirci.
Un tumulto. Soffocato. Non m’importa. Non mi voglio fare domande, non voglio sentire risposte.
Voglio annegare tra le tue braccia, quelle braccia che lo so, sono pronte a stringermi forte, a rassicurarmi, mentre scendo nei miei abissi, nel centro di una coscienza oscura che ho tarpato per tanto tempo, troppo tempo.
Voglio darti credito, voglio credere che mi ami, che non hai fatto altro che pensare a me, in questo anno in cui non ci siamo visti, e che mi è sembrato lungo come un secolo.
Quell’anno passato a lasciarmi divorare dai morsi della nostalgia, che saliva fitta al calar della sera, quando pensavo che era passato un altro giorno senza vederti, senza sentirti.
La mia dipendenza da te. Un’ossessione, una compulsione. Un credermi legata a un qualcosa che di fatto non c’è se non nella mia mente, malata, pervasa solo dalla tua assenza.
Di fatto, cosa mi hai offerto? Baci e abbracci fugaci, solo quello.
Non un progetto, non una volontà di costruire qualcosa che possa cambiare le nostre vite infelici, o forse siamo felici, e non lo sappiamo.
E, se tutto questo è vero, se sono consapevole di essere una nave al centro del mare, una nave ferma senza meta, anche se sono salpata, se mi sono allontanata dal porto; se sono consapevole di tutto questo: perché ti anelo? Cosa anelo?
Anelo l’”Amore”, unica forza capace di abbeverarmi, mentre dissecco lentamente in un deserto affettivo.
Il terzo piano. Il pianerottolo rettangolare, stretto, allungato. Due porte.
La tua, davanti l’ascensore.
Marrone, lucida. Ma stantìa, dentro. Il legno è vecchio, come l’odore del palazzo,vecchio.
Il campanello: un pulsante bianco, in una mascherina d’argento.
Mi apri. I tuoi occhiali dello stesso colore della mascherina.
La tua voce energica, decisa.
Non mi chiedo più nulla.
Depongo la maschera.
– Buongiorno, ti dico.
Entro.